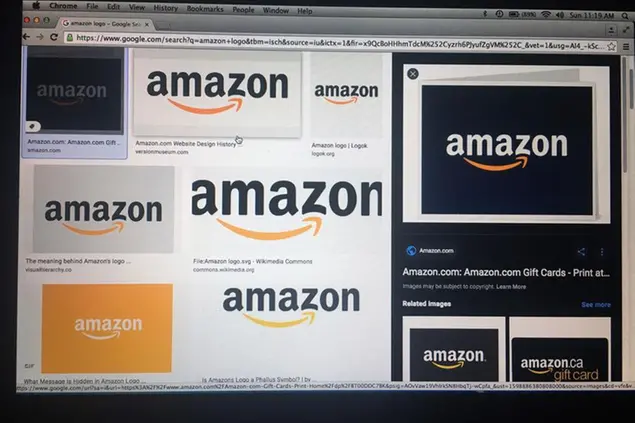- Il quadro normativo sulla tassazione globale pubblicato lo scorso ottobre dall’OCSE con l’obiettivo fermare l’evasione fiscale e limitare la concorrenza fiscale tra i paesi, ma non sembra in grado di colpire le aziende che aveva lo scopo di tassare, come ad esempio Amazon.
- Il primo pilastro si applica solo a società con margini di profitto superiori al 10 per cento. E quindi non alla società americana, nonostante fosse tra i bersagli della tassazione, visto che l’anno scorso ha registrato un margine di profitto complessivo inferiore.
- Nonostante siano ancora diversi i nodi da sciogliere a riguardo, c’è tutta la volontà politica di trovare un accordo. Come testimoniano anche le dichiarazioni trapelate dai ministri delle finanze del G20 riuniti a Venezia, e l’ordine esecutivo per limitare i monopoli firmato dal presidente Biden.
I ministri dell’Economia e delle Finanze riuniti a Venezia per il G20 hanno l’obiettivo di annunciare domani l’accordo definitivo sulla riforma della tassazione delle multinazionali, un’intesa storica che pare sempre più vicina perché voluta dagli Stati Uniti di Joe Biden.
Proprio il presidente americano ieri ha firmato un ordine esecutivo che ha l’obiettivo di combattere i monopoli e promuovere la concorrenza in un’economia americana irrigidita dall’eccessivo potere di alcune mega-aziende. Tra i principali bersagli di entrambi gli interventi ci sono i colossi del digitale, sempre più potenti e sfuggenti, ma la preda più grossa, cioè Amazon, è già sfuggita alla rete della tassa minima globale.
Le nuove regole
Il quadro normativo presentato lo scorso ottobre dall’Ocse con l’obiettivo di fermare l’evasione e limitare la concorrenza fiscale tra i paesi, alla prova dei fatti risulta già inadeguato perché non sembra in grado di colpire le aziende che aveva lo scopo di tassare, come ad esempio Amazon.
Il quadro proposto si basa essenzialmente su due pilastri, il primo che ha l’obiettivo di assicurarsi che le multinazionali paghino abbastanza tasse nei paesi dove registrano la maggior parte delle vendite. Il secondo invece mira a stabilire un’aliquota minima d’imposta per le maggiori corporation mondiali. Se quest’ultimo rappresenta uno sforzo globale ampiamente accettato, soprattutto sulla volontà di evitare una concorrenza tra i vari paesi nell’ambito delle tasse, il primo è il risultato di due anni di sforzi per creare un insieme di regole più adeguate all’economia digitalizzata, e un tentativo di prevenire la proliferazione di leggi divergenti – spesso basate sulle entrate lorde piuttosto che sui profitti – per riscuotere le tasse dove le vendite o i dati degli utenti dei servizi digitali giocano un ruolo importante nel generare profitto.
Niente profitti
Tuttavia, un comunicato dei ministri del G7 ha affermato più di un mese fa come il primo pilastro nel nuovo quadro normativo si applicasse solo a società con un fatturato superiore a 20 miliardi di euro e con margini di profitto superiori al 10 per cento. E quindi non ad Amazon, nonostante fosse tra i bersagli della tassazione, visto che l’anno scorso ha registrato un margine di profitto complessivo del 6,3 per cento. Questo perché nonostante l’azienda tecnologica americana abbia chiuso il 2020 con oltre 13,5 miliardi di dollari di profitti operativi annui, tutto quello che viene guadagnato viene reinvestito per moltiplicare i magazzini, i punti di raccolta, per espandere ancora di più il suo raggio di azione e quindi le quote di mercato. Come dimostrano molto bene i profitti realizzati dalle sue filiali estere e mai rimpatriati perché investiti in attività internazionali per limitare il livello delle imposte sul reddito.
Si tratta di una peculiarità che altre aziende tecnologiche non hanno, e si basa su una solo regola: niente profitti niente problemi. Per come infatti è stato strutturato il business model di Amazon, convivono mercati differenti, alcuni maturi e redditizi, altri nuovi e temporaneamente in perdita, altri ancora che servono solo a portare traffico sul portale. Tutto quello che viene guadagnato viene reinvestito. Per questo per diversi anni un gigante che capitalizza miliardi di dollari in Borsa è andato costantemente in perdita.
Un portavoce di Amazon ha dichiarato: «Amazon paga tutte le tasse richieste in ogni paese in cui operiamo. L’imposta sulle società si basa sui profitti, non sui ricavi, e i nostri profitti sono rimasti bassi dati i nostri ingenti investimenti e il fatto che la vendita al dettaglio è un’attività altamente competitiva e a basso margine». Stando però ai dati raccolti da Morgan Stanley, l’aliquota fiscale effettiva di Amazon è del 14 per cento a fronte di un’aliquota fiscale principale che negli Stati Uniti è del 35 per cento per la maggior parte delle altre aziende.
Separare le attività
L’Ocse stessa, preoccupata di non poter includere aziende come Amazon nella normativa del primo pilastro, ha proposto di considerare singolarmente le varie attività delle aziende. In questo modo sarebbe in grado di tenere conto delle diverse attività e differenziarle sulla base dello loro redditività. Ma si tratta di un problema piuttosto complicato. Inoltre, come ha fatto notare Michael J. Graetz della Columbia Law School in uno studio recente, «la decisione dell’Ocse di basarsi solo su una percentuale specificata di profitti residui, piuttosto che invece di ridistribuire una percentuale fissa più piccola su tutti profitti delle attività di un’impresa multinazionale, introdurrà gravi complessità e incertezze nel progetto del primo pilastro di questa normativa. Rendendo nei fatti non plausibile l’obiettivo di assicurare la certezza fiscale».
© Riproduzione riservata