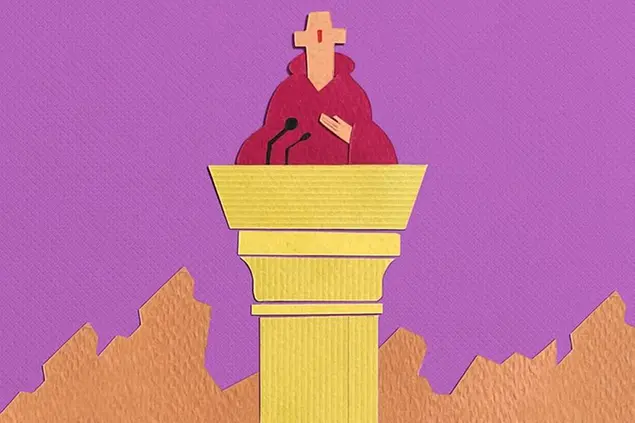- C’è un contrasto geometrico tra la verticalità con cui raccontiamo visualmente Zelensky e i grandi tavoli orizzontali dietro cui siede sempre Putin. Zelensky è in piedi, in alto. Zelensky appare solo, un’isola.
- Questa grammatica visiva, mi pare, ci conforta. La monumentalizzazione di quest’uomo carismatico rischia di sublimare, nella verticalità del podio, gli aspetti materiali che battono alla nostra porta di spettatori abituati a considerare certi isolamenti onorevoli e prestigiosi. Desiderabili addirittura.
- Questo contributo è parte del nuovo numero della newsletter Cose da maschi. Clicca qui per iscriverti gratuitamente alla newsletter e segui tutti i suoi contenuti.
Quanto appaiono sole, in cima ai loro piedistalli, le statue degli uomini illustri che punteggiano, come isole estranee al tempo, i mari di caduchi passanti che lambiscono le città d’Europa. E come apparivano solitari i podi da cui, un tempo, professori quasi tutti maschi si ergevano per spiegare quei monumenti a silenziosi stuoli di studenti rapiti, nelle università delle stesse città. Uomini di carne che parlavano di antichi uomini di marmo, di bronzo, che gli sono sopravvissuti; entrambi abbarbicati su uno zoccolo verticale a riprova della loro importanza.
Il podio del professore
Proprio all’immagine di un’isola ricorreva Pier Paolo Pasolini, mezzo secolo fa, per descrivere il leggio rialzato, quasi fluttuante, del suo maestro Roberto Longhi, forse il più grande storico dell’arte italiano di sempre. A Bologna, sotto il fascismo, lo aveva osservato ergersi ogni settimana su quel podio illuminato, nel buio della sala in cui proiettava diapositive di quadri, affreschi, pale d’altare.
Da persona che era, il professore diventava, a quell’altezza, un’apparizione, una funzione, un ruolo invidiabile. Un cecchino onnisciente, un monumento parlante. Chissà quanto teatro ci fosse, in un simile incantesimo: chissà se si può ripeterlo dabbasso, senza piedistallo e lanterna – o senza essere un luminare coi baffi e il toscanello, tipo Longhi negli anni Quaranta.
Visto che insegno in un’università americana molto forte in storia dell’arte, visto che i miei corsi hanno spesso a che fare con la storia dell’arte, mi capita di fare lezione in aule di storia dell’arte, progettate per somigliare a quella sala bolognese. Anche se il proiettore ora è digitale e la cattedra in sé (almeno dove lavoro io) non è più una cosa da maschi, il podio con la sua lucina, col microfono, col grande leggio inclinato pronto per i miei appunti, c’è sempre. Io però lo diserto, mi fa ridere. Mi ricorda la battuta che i secchioni come me si sentono giustamente ripetere sempre: scendi dal piedistallo.
Scendere dal piedistallo
Mi domando se grandi storiche dell’arte donne del Novecento, come la geniale Paola Barocchi, facessero lezione dal podio. Immagino di sì. E tuttavia c’è qualcosa di dichiaratamente maschile in quell’oggetto pensato per focalizzare l’attenzione, per far svettare anche il più basso o curvo dei corpi sopra tutti gli altri, per sancire chi è che parla in uno spazio – e separarlo dalla massa che, invece, ascolta.
È la stessa maschilità dei rialzi su cui posiamo le statue pubbliche, e permane anche quando quei rialzi sono abitati da donne, invece che da uomini, di pietra o di metallo.
Per rimanere nelle mie vicinanze, il busto marmoreo (intenzionalmente augusteo) di una illustre rettrice del mio college rimane, in biblioteca, sul suo piedistallo anche ora che sappiamo che era una zelante antisemita e razzista sfegatata, nonostante le studentesse siano riuscite a far togliere il suo nome, un tempo leggendario, dall’edificio falso-gotico in cui si trova il mio studio.
Le colonne su cui innalziamo certi personaggi, certi ruoli, tendono a essere affette da una specie di priapismo: persino dei monumenti fascisti ci inquieta l’abbattimento. Qui in America, dove negli anni Sessanta sono sorte statue di presunti eroi dell’ottocentesca guerra di secessione (eroi che parteggiavano per la schiavitù degli afroamericani, eretti, cento anni dopo, da chi parteggiava per la negazione dei diritti civili degli afroamericani), si dibatte su come preservarli, si propone di musealizzarli, ci si pone l’assurdo problema di come rispettare ovvi simboli d’odio e di supremazia solo perché hanno trascorso qualche decennio in cima a un rialzo, al centro di una piazza.
Scendere dal piedistallo, insomma, è una faccenda complicata. E si complica ancora di più per chi non era destinato a ritrovarsi lì.
Monumentalizzare Zelensky
Scrivo queste righe mentre, in Europa, l’esercito russo incombe su Kiev, e si dibatte assai confusamente sulla resistenza ucraina. In America la discussione suona assai più astratta: sebbene i social media rimbalzino storie anonime e umanissime (una bambina che canta la canzone di Frozen nel rifugio antiaereo, un’altra che entra da profuga in una scuola italiana, ricevuta dall’applauso dei nuovi compagni di classe) e vadano in visibilio per le scene di trattori agricoli che prendono a rimorchio i carri armati di Putin per riportarli oltre il confine, mi sembra che al centro della narrazione mediatica più editorialmente curata ci sia soprattutto un uomo: Volodymyr Zelensky, il sesto presidente dell’Ucraina.
Ritornano di continuo le immagini delle sue conferenze stampa, dei suoi discorsi in russo al popolo che ribadisce di non considerare suo nemico. Sono quasi tutti discorsi pronunciati da un podio, anche se progressivamente sono cambiati molti dettagli (soprattutto gli abiti che il presidente indossa, sempre meno formali e più allusivi al suo ruolo attivo e presente nel conflitto).
C’è come un contrasto geometrico tra la verticalità con cui raccontiamo visualmente Zelensky e i grandi tavoli orizzontali dietro cui siede sempre Putin quando parla della guerra, o nelle foto che si stagliano immense sugli schermi a led dietro i commentatori televisivi. Zelensky è in piedi, in alto. Zelensky appare solo, un’isola. Zelensky parla, con riluttante ma virile disponibilità a incarnare le speranze collettive, e l’ovest ascolta, da sotto il podio. Questa grammatica visiva, mi pare, ci conforta.
La monumentalizzazione di quest’uomo carismatico, passato dai set delle commedie alla presidenza in un teatro di guerra, rischia di risolvere nell’anticaglia banalizzante dell’eroismo, dell’individuo (dell’underdog, come si dice qui) tutte le complesse responsabilità che dovremmo considerare, contemplando un conflitto da cui non possiamo dirci estranei. Rischia di sublimare, nella verticalità del podio, gli aspetti materiali che battono alla nostra porta di spettatori abituati a considerare certe solitudini, certi isolamenti, onorevoli e prestigiosi. Desiderabili addirittura.
È una cosa da maschi ridurre una guerra potenzialmente mondiale allo scontro tra due uomini, tra due volontà e due storie?
Mai più soli sulla colonna
Schopenhauer, nella Metafisica del bello, insisteva sul fatto che i monumenti italiani sarebbero superiori a quelli tedeschi perché generalmente posti su piedistalli più bassi. Così sono visibili, diceva: familiari, godibili nei loro dettagli invece che siderali come quelli nordici.
L’idea di Schopenhauer colpì enormemente Giorgio de Chirico, un pittore capace di immaginare carovane di statue classiche e risorgimentali animarsi all’improvviso per scendere dai propri zoccoli e mescolarsi alle persone in carne ossa delle loro città, diventando indistinguibili da loro. Negli scritti di de Chirico i monumenti diventano spesso compagni di via, incontrati per caso, e in quelli di suo fratello, Alberto Savinio, l’altissima colonna su cui si staglia la statua di Ariosto a Ferrara si piega, a un certo punto, come una canna al vento, spezzandosi e liberando finalmente il poeta di marmo nella piazza che porta il suo nome. Lassù era passivo, annoiato, inutile. Appena tocca terra si stiracchia, si gratta, si copre gli occhi perché improvvisamente vede la luce, e scappa verso il tram per unirsi alla compagnia degli uomini moderni.
Come chi insegna, per farlo bene, deve ormai scendere dal podio e mescolarsi alla comunità di studenti con cui interagisce, così gli eroi letterari, politici o militari di un tempo devono forse abbandonare i loro piedistalli verticali e lasciarsi interrogare: ci servono ancora? li vogliamo tra noi? ci fanno compagnia? D’altronde persino gli anacoreti della Siria e della Russia, nella tarda antichità, non potevano bastare a sé stessi sulla cima delle colonne che abitavano per testimoniare, nell’ascetismo, la propria fede. I monaci stiliti, pur vedendo più degli altri e offrendo alla città il visibile martirio del loro isolamento verticale, dipendevano dai confratelli, che quotidianamente li visitavano per issare sul piedistallo le provviste.
Ecco, se non si riesce proprio a spezzarli gli zoccoli su cui erigiamo i nostri eroi (fatti di marmo o di rassicuranti ideali), trasformiamoli almeno in percorribili longitudini per trasmettere nutrimento e senso, quando non munizioni, a chi, sulla sommità, vi confiniamo.
© Riproduzione riservata